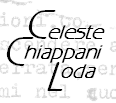![]()
Pubblicazioni
Scelta di articoli editi sulla rivista Pro Natura
Alcuni articoli editi su temi naturalistici sono stati raccolti in Pagine scelte, pubblicazione della Editodame.
Ancora sul problema ecologico (1985)
Una visita al Parco Nazionale degli Abruzzi
Ancora sul problema ecologico (1985)
In questi ultimi tempi il problema ecologico ha assunto proporzioni macroscopiche al punto che nessuno più può ignorarne l'esistenza se non proprio misurarne l'entità. Tutti ne parliamo, tutti ne discutiamo, ma in troppo pochi ci sentiamo così coinvolti da essere spinti a fare qualcosa di concreto purchessia, relativamente al nostro piccolo o grande raggio d'azione.
Questa è una frase che ho usato tante di quelle volte da sentirmi – ora che la ripeto – come un disco che si sia incantato su tali tre o quattro parole. Comunque un fatto nuovo mi induce a riprendere il discorso.
Proprio in questi giorni ho terminato la lettura del volume Il ritorno degli esuli, dello scrittore americano Malcolm Cowley, vissuto nella prima metà del nostro secolo. Alcune righe di detta opera mi hanno profondamente colpita portandomi a riflettere su un paio di fatti che, magari, per tanti lettori possono anche essere scontati: si iniziò ad avvertire il disastro ecologico già alcuni decenni fa e tale andazzo – né più né meno che un'orda di cavallette premeditate, o meglio, destinate a distruggere – si sposta, inesorabile e mostruoso, da un continente all'altro lasciando come scia, cicatrici irreversibili ed esiziali per ogni creatura vivente.
Ecco le righe: "… la regione era mutata da quando la nuova strada di cemento l'aveva attraversata: i boschi erano scomparsi, le fitte querce erano state abbattute e non rimanevano che ceppi, sterpaglia, rami secchi ed erbacce, là dove si trovavano boschi".
E più avanti: "Un anno dopo l'altro aumentava il numero delle fabbriche che impiegavano un numero sempre più grande di lavoratori producendo un maggior numero di beni per ora-uomo; un anno dopo l'altro aumentava il numero delle automobili sulle autostrade, si infittivano le folle e diventavano più abbaglianti le luci nelle metropoli, mentre nei sobborghi si moltiplicavano le case completamente attrezzate con radio, frigoriferi, aspirapolvere e tostapane automatico. Anno per anno le pagine pubblicitarie diventavano sempre più spudorate; blandivano, lusingavano, tentavano, esercitavano pressioni sul pubblico o addirittura lo spaventavano inducendolo a vendere o a gettar via tutto quello che s'era messo in casa l'anno prima, e per destar l'invidia dei vicini acquistando a comode rateazioni mensili […]. Il sistema degli acquisti a rate aveva indebitato un sempre maggior numero di persone: tutti si sforzavano di arrotondare lo stipendio meritandosi premi speciali, e di conseguenza avevano sempre meno tempo libero per godersi i nuovi acquisti […]. Gli scrittori avevano cominciato a lamentarsi affermando che il progresso lasciava sempre meno tempo libero per leggere, per fare del giardinaggio, per trascorrere le serate in famiglia, e pochissimo campo libero alle virtù come l'indipendenza e l'onestà".
Reputo le osservazioni di Cowley, almeno in questo contesto, non eccessivamente cariche di vis polemica; nondimeno giungo ad una duplice conclusione: in queste righe il problema ecologico viene adombrato in un tronco con due rami strettamente correlati tra loro. Il primo riguarda la protezione vera e propria della Natura; l'altro il pericolo dello slittamento, purtroppo già in atto in modo eclatante, verso la folle civiltà consumistica fatalmente tesa alla distruzione totale delle risorse vitali della Terra, per il profitto immediato di pochissimi. I quali, purtroppo, a mano a mano che perdono il ben dell'intelletto, stringono con più caparbietà il coltello che tengono dalla parte del manico, decisi a non cedere di un solo millimetro, o – chi lo sa!? – impossibilitati ormai a farlo, al buon senso.
Ogni mobilitazione sembra (e forse lo è) ormai inutile; ma la volontà e la speranza devono essere le ultime compagne ad abbandonare il combattente in buona fede.
Una visita al Parco Nazionale degli Abruzzi
Inizia in una parte qualsiasi dell’Appennino Abruzzese, triste e così glabro da far senso.
Per gli sprovveduti il termine Parco implica un immediato concetto: tripudio di flora e fauna. Anch’io sono una sprovveduta. E vulnerabile. Via via che ci inoltriamo mi convinco sempre di più che il primitivo concetto potrà essere adeguato dappertutto magari, ma non qui. Il torpedone ha già percorso decine e decine di chilometri, altrettante ne restano da percorrere in un paesaggio ricco di indubbio fascino. Infatti la struttura orografica, anche se solo nelle sue grandi linee, è rimasta pressoché inalterata. Almeno quella!
Abbacinante roccia calcinata, liscia o scabra, imprevedibile nei suoi carsici spuntoni, crepacci, corrugamenti, incavi. Suolo martoriato da cui le denudate radici delle magre conifere si protendono, dignitosamente anelanti, in tacita invocazione. Ai miei occhi esse appaiono entità dolorosamente accusatrici. Incasso in malo modo, anche se pure l'orrido ha il suo fascino.
Non un suono, un verso, un fruscio, un fremito, un soffio. Soltanto il disumano silenzio del terzo regno della natura, quasi sovrano incontrastato. Silenzio non beatificante ma che, ugualmente, ci fa meditare. Sì, perché se dapprima ritenevamo probabile un rintanamento più interno della selvaggina, ora non ci pare più nemmeno possibile.
Quanti animali, grossi e minuti, possono essere scampati alla ingiustificabile e incomprensibile sete di distruzione dell’uomo?
Qualcuno sonnecchia, qualche altro conversa tranquillamente con il suo vicino di posto. Il pullman intanto inghiotte chilometri ronzando sommessamente e io guardo, con intensità vieppiù crescente a destra e a sinistra. Non che l’intenso mio scrutare a qualcosa approdi. E nemmeno mi fa grazia di un fastidioso malessere che sale dentro: almeno udire un battito d’ali: almeno scorgere il fugace guizzo d'una lucertola che vengano ad offrirci il loro umile ma essenziale messaggio di vita!
Vanamente. Eppure, con cocciutaggine, con zelo, voglio credere che questa sia un'ora, una giornata, un periodo particolarmente infausto: totalmente orbato per ragioni di stretta connessione a cicli naturali, a naturali avvicendamenti.
Ma ecco Pescasseroli, la Mecca di questa "oasi naturalistica". Concedo al cuore d'allargarsi.
Dio mio, le delusioni, come le disgrazie, non vengono mai sole, dunque. Di verde ce n’è, quello sì. Anche se è il verde sofisticato dei giardini. E basta.
Entriamo nel piccolo zoo che, in quanto a squallore, supera tutti i suoi consimili, credo. Una pena indicibile.
Ci si presenta quasi subito un orso. Un grosso orso malinconicamente e palesemente artritico. tanto che, al solo vederlo uno si sente il magone e pensa all’eutanasia.
La bestia, dondolando il capo a ritmo opprimente, misura in lungo e in largo, in un instancabile carosello di illusioni e delusioni la sua prigione recintata da un’alta rete metallica che delimita un fossato profondo. Tetra perseveranza che unisce in un lungo rosario di interminabili ore i grani d’una speme che nessuno va a nutrire.
Un poco oltre, il recinto dei lupi. Ciò che vedremo è stomachevolmente scontato. Quattro occhietti opachi di struggente nostalgia, si posano su di noi per un brevissimo istante. ma le otto zampe non smettono il loro frenetico, meccanico deambulare, in quel breve spazio di terra battuta cosparso di lattuga. (Cretinissima derisione?).
Ancora una fila di abitacoli in muratura, l’uno attaccato all’altro. E di grucce con il loro ospite pennuto, una puzzola e qualche altro esemplare chiudono la serie.
Ma in questo eden si vuole strafare, sembra. Chissà perché quattro o cinque bastardi sono trattenuti alla rete che recinge lo zoo, da cortissime catene. Abbaiano furenti in un disperato appello e pesticciano il suolo che, nel loro breve raggio d'azione, non presenta più un grammo di clorofilla.
L’aria è fresca e profumata nei vialetti che corrono simmetrici sotto gli alberi ben allineati e rigogliosi. Tutto intorno la chiostra delle cime appenniniche, accarezzate un po’ a sghimbescio dal sole che si avvia all’occaso, incombe nella sua incontrastata imponenza; ma quanto indifesa! L’ombra, dall’alto, scivola lungo i fianchi grigioverdi, indugia quasi restia negli anfratti per ristagnare quindi in pozze sempre più ampie.
E queste creature che vedo qui, asservite inutilmente e quasi senza contropartita dalla stupidità degli uomini dovrebbero a quest'ora ammantarsi dombra, immergersi nel profumo del sottobosco e nel silenzio; dovrebbero entrare nelle tane o uscirne a seconda che le guidi l’istinto.
Fantasticherie incomprensibili ai più e vane, che tiranneggiano caparbiamente il mio spirito annegandolo in una ristagnante tristezza tutta note pessimistiche e sfiduciate. In tale bozzolo buio adagio i sensi e l’anima, senza lottare, senza recepire altro che i miasmi della più brutale insensibilità.
Ecco un lievissimo fruscio che sento più che udire. Alzo lo sguardo quasi con trepidazione: un paio di scoiattoli (io almeno tanti ne scorgo) saltano con la grazia e l’agilità loro peculiari, di ramo in ramo, di albero in albero, liberi. Ecco la parola magica: essi sono veramente liberi. Finalmente una nota gentile sulla quale prolungare il suono fino a chiudere la sinfonia. Ma il suo tempo è brevissimo: subito viene brutalmente stroncata da cacofonici apprezzamenti. Perbacco, ce n'è di gente fortunata a questo mondo! Costoro, dopo aver proditoriamente stuzzicato i prigionieri e lanciato loro qualche frizzo grossolano, alzano lo sguardo sulle chiome degli alberi perché vedono alcune teste girate in su.
- Che cosa guardate di bello? -
- Gli scoiattoli. -
- Oh, Signore, se no vedono tanti anche alla televisione. -
- Che peccato, però: nemmeno una scimmia. -
Beati loro!
Grillo Martino
Tempo fa ebbimo, forse per un paio d'anni, un grillo in casa. Deducemmo che fosse un Grillo Domestico (o del Focolare), rari in ltalia, dal fatto che pareva trovarsi a suo perfetto agio, scorrazzando per tutto l’appartamento e scoprendo gli angoli più riposti dietro ogni mobile, grande o piccolo che fosse.
Lo battezzammo Martino e pensammo che poteva essere un lontano discendente del Grillo Parlante di Pinocchio, ma non potemmo averne la conferma in quanto Martino non ci offrì mai la sua saggezza sotto forma di consigli più o meno richiesti; si accontentò sempre di "cantare" a tutto volume come un piccolo invasato.
Più di una notte ci svegliò di soprassalto con i suoi furiosi cri-cri proprio dietro le nostre teste o a lato delle orecchie: poteva essere rintanato tra il muro e la testiera del letto o dietro uno dei comodini.
Allora mio marito od io si emetteva un sonoro sssst! La bestiola si zittiva di colpo; ma la pace durava ben poco, appena qualche secondo, e subito udivamo un cri-cri timiduccio e molto più lontano, seguito immediatamente da altri cri-cri un poco più audaci, più audaci ancora, fin che il diapason era presto raggiunto e noi ci si trovava a sorridere nella nostra impotenza.
Parecchie volte tentammo di scoprirne la tana del momento, seguendo il suo stridìo. "Deve essere dietro la libreria", "Ma no. Per me è dietro il pianoforte", "Mai più: non senti che “canta” dietro la credenza della cucina?".
Per essere sinceri non ponemmo mai molto impegno per scoprirlo: ci sarebbe sembrato quasi un tradimento. E poi temevamo di spaventarlo: era così piacevole avere un grillo tanto prepotente in casa!
Ma un giorno, anzi una notte, ci accorgemmo di non udirlo più constatando che non saremmo stati in grado di dire quando Martino se ne fosse andato. O fosse morto, chi lo sa.
Sono passati molti anni ormai e devo confessare che, da ultimo, Grillo Martino m’era totalmente uscito dalla memoria.
Fino a poche settimane fa quando all’improvviso, una sera, udii un cri-cri lievissimo provenire dall’armadio, assolutamente non tormentato dai tarli.
Chiusi di colpo il libro che stavo leggendo e spensi la lampada sul tavolino da notte, mentre l’emozione mi sommergeva. Forse era Grillo Martino che tornava indebolito, invecchiato e solo, attratto dalla mia solitudine.
L'uomo, generalmente, paventa la solitudine e quando può si procura la compagnia di cani, gatti, uccelli, criceti. Se impossibilitato a ciò si accontenta anche di meno fissando la sua attenzione su creature minori come un ragno che tesse scrupolosamente la sua tela, oppure un bruno rigagnoletto di formiche che s’affatica intorno alla scorta d’ammassare.
lo sono più fortunata: nelle mie giornate silenziose ho un cane; ed ora anche un grillo che mi offre il suo filino di suono debole, timido.
Forse anche lui è rimasto solo.
Finalmente il nido è vuoto
così ora posso vederlo da vicino in tutta tranquillità. Salendo su una corta scala a pioli lo "colgo" come un frutto, osservandolo con interesse: una ciotola bruna, leggera, ma saldamente connessa in tutte le sue parti, fatta con fili d'erba, foglie, piccole radici, nonché brandelli di cellofan e di carta.
La costruì una coppia di merli nella biforcazione di due rami del cipresso argentato a poco più di un metro dal mio naso se sto affacciata alla finestra della mia camera da letto, la quale si trova a piano rialzato.
Dopo un inverno rigidissimo la primavera venne funestata da furiosi temporali con raffiche di vento impressionanti. Quante volte temetti di vedere il nido sbalzato chissà dove mentre l'albero veniva investito da esse! Oppure spiavo con apprensione la femmina alla cova temendo che venisse "diluviata" dalla pioggia battente. Invece tutto andò bene.
Ecco, avere un nido alla distanza di poco più di un metro da una finestra molto usata fa insorgere problemi. Io almeno me li creai facendo sempre molta attenzione a non far troppo rumore nell'alzare o abbassare gli avvolgibili; non scuotendo più nulla fuori dal davanzale. Tutte azioni che soltanto ora mi accorgevo di quanto meccaniche e frequenti fossero.
Tuttavia appurai che chi stava alla cova (solo la femmina assolve questo compito, il maschio limitandosi a stare sul bordo del nido a controllare le uova durante le brevi assenze della compagna) pur vedendomi muovere, anche se con gran riguardo, a così breve distanza non si scomponeva, credendo probabilmente di essere nascosta.
Siamo alla prima decade di aprile e già intravedo un movimento diverso nel nido. Aguzzando la vista, sia pure poco distintamente, vedo tre o quattro enormi becchi voracemente spalancati, in attesa. D'ora in poi il lavoro dei genitori diventerà frenetico: i nidiotti reclameranno cibo in continuazione ed i loro robusti cip-cip riempiranno l'aria per periodi di lunga durata.
Un pomeriggio sul tardi mi pare di capire che il cinguettìo non provenga dal nido. Contemporaneamente odo l'abbaio di Gionata. Mi precipito fuori: il mio bastardo sta puntando qualcosa tra i giacinti pesticciati e ormai sfioriti ai piedi del cipresso; accorro e vedo un merlottino che cinguetta disperato, vicinissimo alla bocca del "drago".
Con una mano afferro immediatamente il cane per il collare, trattenendolo a fatica, mentre con l'altra sollevo il povero uccellino, tondo tondo come una piccola palla munita di becco e dal cuore impazzito.
Ora però non so che fare: vorrei rimettere il merlottino nel nido ma da terra non riesco perché troppo in alto. Fortunatamente a farmi decidere ecco intorno a me uno svolazzare scomposto, unito a strida acute che non esito a definire isteriche: è la coppia dei genitori che vede il piccolo in mortale pericolo e non sa come salvarlo.
Qualcosa di agghiacciante quel dolore di due esseri tanto vulnerabili, tanto esposti ad ogni sorta di rischi. In un amen deposito il merlottino bene in vista nel vialetto e porto in casa il cane. Da questo momento controllerò ogni movimento di quell'indemoniato; e devo dire che non è impresa da poco E sempre da quel momento, spostandomi da una finestra all'altra della casa, che è isolata sui quattro lati, posso seguire l'evoluzione dei piccoli, che dura una dozzina di giorni, fino alla loro autosufficienza. Escono dal nido con un giorno di distanza l'uno dall'altro a seconda del tempo di schiusa delle uova; una volta a terra restano nascosti nell'erba, mentre la femmina li chiama a brevi intervalli con un verso quasi identico a quello della gallina chioccia. I piccoli allora lanciano i loro sommessi cip-cip per segnalare la posizione dove i genitori li raggiungono portando cibo, soprattutto costituito da lombrichi che dissotterrano con abilità.
Una volta ero appostata alla finestra del tinello, dal cui vetro avevo scostato un poco la tendina per seguire i movimenti di un piccolo che Gionata aveva quasi azzannato, per giocarci, qualche minuto prima. Dedussi che l'uccellino stava bene dal fatto che il suo richiamo era netto, inoltre si spostava a saltelli puliti tra l'erba che lo copriva quasi completamente. Il cane intanto sbraitava addosso a me perché l'avevo chiuso in casa.
Ad un tratto vedo arrivare planando uno dei genitori con il cibo nel becco, e subito odo una specie di stridìo allarmato provenire dal tetto dell'abitazione confinante con il mio giardino. Immediatamente il merlo che porta il cibo cambia direzione di volo senza atterrare, di sicuro per stornare la mia attenzione dal suo piccolo. Un sistema di difesa della prole sempre commovente che potrò seguire più volte.
Abbiamo detto di autosufficienza raggiunta, parlando di nidiacei usciti dal nido, dopo una dozzina di giorni, ma non è esatto: in pratica i merlotti dipendono dai genitori a lungo, fino a quando, cioè, sono già grossi come loro, distinguibili soltanto dal piumaggio che non ha perso del tutto la sua tendenza al marrone e dalla coda non sviluppata completamente. Essi rincorrono i loro "vecchi" con petulanza e con prepotenza insieme, esigendo l'imbeccata. Mi capita spesso di vederli, sprizzanti simpatia, esigere dal nutritore di turno che spezzetti loro una briciola di pane, da me lasciata lungo i muri perimetrali della casa, come al solito, ma che, secondo il loro metro, è troppo grossa. E la madre o il padre a volte li accontentano, a volte no, girando le spalle indignati per tali capricci.
Ora il nido è vuoto e mi chiedo quanti dei quattro merlottini, di cui è stato la culla, siano arrivati all'età adulta.
Mas de l’Ancienne Souloze
Al primo colpo d'occhio l'insieme riesce piuttosto sgradevole: si è come disturbati da una disarmonia. Un complesso di costruzioni molto distanziate tra di loro, sparse su circa quattromila metri quadrati di terreno ondulato in blande collinette; costruzioni di ogni foggia, misura e materiale senza un qualche criterio apparente.
La casa padronale, che sorge pressappoco al centro, è ampia e bassa, d'una linearità architettonica sconcertante, ed è vecchia di circa tre secoli. Nel capannone più grande, abbastanza distante da essa, alloggia la mandria dei tori, una trentina di capi tra giovani e adulti. Essi scorrazzano liberi nella vasta proprietà (720 ettari). Potrebbero portarsi anche sulla rotabile, stretto nastro asfaltato di notevole traffico e importanza come sono, generalmente, le strade le strade della Provenza: non c'è ostacolo alcuno che impedisca loro di accedervi. Il grande cancello di legno e rete metallica rimane sempre spalancato e si addossa alla siepe incolta intricata di rovi, biancospino e rose selvatiche. Inchiodata al tronco di un grosso pino marittimo, che fa da limite, una tavola lignea, scritta con vernice nera, ci avvisa: "Attention! Toreaux de combat".
Sono stupita di questo che attribuisco a pericolosa incuria e ne chiedo ragione. Gli animali - mi spiegano subito - non vanno mai sulla strada per un accorgimento semplicissimo. Sul piccolo ruscello che costeggia tale strada c'è un minuscolo ponte, che immette appunto nella carrareccia conducente al Mas. Esso è formato da tante verghe di ferro, poste una accanto all'altra, nel senso della lunghezza, ma messe in modo che anche il solo peso d'una persona le faccia muovere rumorosamente. Le bestie si spaventano e si ritirano subito. Stento a crederci. D'altra parte pare che sia la sacrosanta verità dal momento che gli animali sono sempre liberi ed il cancello sempre spalancato, salvo in alcune occasioni che non hanno nulla a che fare con i tori.
Ad poche centinaia di metri in linea d'aria, dove la proprietà confina con Miramas - cittadina da cui dipende territorialmente - c'è l'arena, non ampia e strutturalmente semplice, dove si svolgono i rodei e le "mis-à-mort".
Fervono già i preparativi per la "fête", come viene chiamato lo spettacolo all'arena. Fra un paio di giorni, natura e bestie, verranno crudelmente violentate. Noi, è logico, non vi assisteremo, anche se al Mas ci sono già alcuni ospiti importanti venuti addirittura da Parigi; e altri sono attesi da luoghi più vicini, specie da Marsiglia.
Striscioni, bandiere, coccarde sono ovunque: una vista angosciosa dal momento che il tutto è simbolo di tanta barbarie. Un peso così gravoso che riesce a neutralizzare la dolcezza indiscutibile della sera ormai inoltrata, colma di freschi sussurri e di gradevoli profumi indefiniti.
Spunta di nuovo il sole, finalmente, che salutiamo entusiasmo perché ci libera dalle terribili fameliche zanzare che ci hanno tormentato quasi tutta la notte nonostante buio totale e zampirone. Qui, tra Camargue e Croix, le zanzare sono regine.
Intanto il cra-cra dei numerosi corvi che nidificano qua intorno, crea una nota malinconica: forse dipende tutto dal pensiero della "fête". Ed è un peccato perché lo scenario è stupendo. Dappertutto, ove non ci siano i filari delle classiche viti bassissime della zona, o le distese di lavanda, si trovano cardi e rosmarino soprattutto, il quale, investito dal calore violento del sole, emana un penetrante gradevole aroma. Sotto questi cespugli sono frequenti le tane dei conigli selvatici. Un paio ci è saettato davanti: visione tenera e fuggevolissima di pelo grigio-rossastro.
Tutta la bassa collina ove sorgono le costruzioni (e gran parte delle costruzioni stesse fatte con blocchi di materiale preso in loco) è formata di roccia fossilifera. Quasi esclusivamente pecten e bàlani che si staccano senza fatica perché di epoca relativamente recente. Ne raccogliamo gran quantità, basta chinarci, come su una spiaggia un po' speciale.
Ora ci spostiamo su un cocuzzolo per ammirare le rovine di Miramas la Vieille sullo sfondo ceruleo dell'Etang du Berre che pare congiungersi con il Mediterraneo.
Ma la contemplazione viene interrotta dalla vista della mandria dei tori che attacca indolentemente la carrareccia e si avvicina sempre più a noi. Ne abbiamo paura, ma l'addetto ci tranquillizza assicurandoci che sono completamente innocui. Anzi, aggiunge che egli parla loro ed è capito perfettamente. Questo ci intenerisce ma non ci toglie del tutto il timore. Ora le bestie hanno invaso la stradina ancora in ombra, chi accosciandosi, chi ciondolando pigramente per ammazzare il tempo. Da lì infatti non si sposteranno fino a che l'ombra non sarà scacciata dal sole. E noi dobbiamo per forza transitarvi, e con una "cinquecento"!, nella quale abbiamo preso posto frettolosamente.
- Piano, piano, - raccomanda l'esperto che si muove tra i bestioni con grande disinvoltura, cercando di convincerli a lasciarci un po' di posto. - E soprattutto non toccate il clacson perché lo prenderebbero come una minaccia reagendo in modo violento. -
Dopo aver chiuso ben bene i finestrini, iniziamo la discesa con esasperante lentezza e un gran batticuore. Ma ecco che ad un tratto, proprio davanti, ci si piazza un torello. Ha tutta l'aria di un bambino curioso e giocherellone. Guarda la nostra utilitaria, anch'essa indifesa come un cucciolo, con interesse. Chissà se sta pensando che potrebbe giocarci infilando le corna nei suoi fianchi!
Il guaio è che a pelo gli sta un adulto, la più grossa bestia del branco. Le corna bluastre e micidiali puntate su di noi che sfiorano il vetro del finestrino e l'occhio attento avvertono che sta sul chi vive, in difesa del piccolo. Un gesto inconsulto da parte nostra e non esiterebbe un secondo a ribaltare la vetturetta.
Fortunatamente poco dopo l'interesse del torello si rivolge altrove così che anche il "patriarca" allenta la tensione spostandosi e noi siamo liberi di procedere, anche se a passo di lumaca e sempre con il batticuore, tra quelle masse nere, indolenti.
Gli animali ci seguono con sguardo liquido e pacifico, mentre vivono la loro vita fatta di acqua, di erba e di ombra.
Perché la "mis-à-mort"?
Il pettirosso
Ecco l'enorme fico che, in pochi anni, s'è fatto adulto e ricco. Ricco di foglie ruvide e tenaci, ricco di frutti succulenti che riusciamo a cogliere solo in minima parte, per cui, a maturazione, coprono il suolo intorno al tronco, della loro polpa rossa. Ma ora siamo a marzo e, foglie e fichi sono solo in potenza: sono nella linfa che sale dalle radici su, lungo il tronco, fino all'ultimo dei rametti che sovrastano il tetto della rimessa, che si sacrificano sotto la gronda ripiegandosi all'indietro, che lambiscono il tetto della casa.
Striature nere rigano fusto e rami color cenere: sono quelle lasciate dall'umidità invernale che colò nello smog; ma il mio fico non è propriamente un povero albero di città: ha tanto spazio tra rimessa e casa e di esso approfitta. Siamo a marzo, dicevo, e il miracolo di nuove gemme s'è compiuto. Tra di esse, ignare e turgide di promesse, una trentina di passeri e merli fedeli fanno gazzarra. Chissà se ricordano la dolcezza dei frutti settembrini che essi fanno cadere a colpi di becco!
Sono ben pasciuti questi uccelli perché, oltre a briciole abbondanti, sparse durante tutto l'inverno, avevo lasciato alcuni grappoli di uva fragola sulle viti che formano un chiosco lì, vicino al fico, nonché vari cachi corposi, dal colore brillante di piccoli soli autunnali appesi ai trami ormai spogli di foglie.
Tutto ciò non solo per i passeri e per i merli, ma anche per il pettirosso, solo soletto, che sverna qui da più stagioni, ormai. A dire il vero non sono mai riuscita a capire se sono di più ma che si presentano uno per volta o se veramente è una povera creatura solitaria quella che vedo.
Alingo, il gatto dal mantello che non ha un solo pelo men che candido, con due enormi occhi cangianti dal verde al giallo fosforescente, e Gionata, il cane dalla taglia piuttosto piccola, in cui prevale tra le molte razze frammiste da chissà quante generazioni, quella del setter, guardano sempre profondamente interessati quello svolìo. Il gatto ingordamente, si capisce, arrampicandosi svelto come una saetta, ora su un ramo ora sull'altro ma rimanendo sempre scornato; frustrazione che palesa con un frenetico dimenar di coda. Il cane, invece, spiccando goffi salti e rimanendo appoggiato per qualche secondo, con le zampe anteriori, al tronco, ogni volta viene puntualmente da me per mugugnarmi il suo malcontento.
Purtroppo capita, anche se assai di rado, che Alingo nelle sue battute di caccia, sia fortunato; e, quando almeno me ne accorgo, devo intervenire onde sottrarre ai suoi artigli, terrorizzate lucertole tanto vulnerabili, o topini patetici nel loro struggente squittire, o infelici nidiotti.
È pur vero che per ogni occasione di queste offro al gatto una contropartita fatta di un morso di formaggio; ma la bestia non ha mai visto di buon occhio questo mio intromettermi per sottrarle ciò che si è onestamente guadagnata, secondo la sua logica.
Gionata, quando sia presente a questi armeggi, non sta più nella pelle dalla gioia e mi dà man forte con ogni mezzo. Mi chiedo spesso che cosa possa passargli per la mente: aiuta la padrona in modo disinteressato? Gioisce nel vedere quel cacciatore tanto più fortunato di lui rimanere a bocca asciutta? Forse, molto più semplicemente, è contento perché, se Alingo avrà un pezzetto di formaggio a lui andrà una caramella o un biscotto.
Non riuscirò mai a saperlo, come non riuscirò mai a sapere che cosa avvenne avanti che - un paio di mattine fa - mi precipitassi in giardino richiamatavi dai versi rabbiosi del gatto contemporaneamente all'abbaio indemoniato del cane. Il pandemonio si sgranava sulla terrazza dove vidi subito Alingo nell'atteggiamento tipico dell'offesa-difesa, ossia, schiena inarcata al massimo, coda grossa il doppio del normale per tutti i peli ritti. Di fronte gli stava Gionata non meno battagliero: zampe anteriori divaricate e saldamente aderenti al suolo, denti scoperti in un ringhio deciso... Ma che cosa giaceva in terra in mezzo a loro? Me lo chiesi vedendo un oggetto che, di primo acchito, non riuscii a identificare. L'incertezza tuttavia durò poco: capii in brevi attimi che tra quei due indemoniati stava il mio povero pettirosso.
Il meschinello era malamente accovacciato con l'ala sinistra allargata, evidentemente molto offesa. Mi precipitai a raccoglierlo constatando che era ancora vivo; ad un affrettato ma attento esame appurai che non aveva altre ferite, solo il suo piccolo cuore impazzito sembrava volergli saltare dagli occhietti sbarrati.
Non stetti a far supposizioni: il pensiero principe, in quel momento era di far qualcosa di concreto per la povera vittima; e mentre rientravo in casa con il pettirosso tra le mani, pensai che il poverino doveva la vita all'antagonismo degli altri due trovatelli.